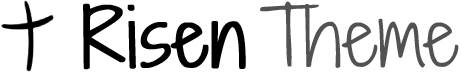A 24 anni sono andata a lavorare alla Borgognan. Nel periodo di preparazione dello sciopero, essendo appena reduce da un procedimento dinanzi al Tribunale Speciale, per le solite misure di cautela, ero tenuta in disparte dai compagni. Tuttavia, s’intende, davo il mio contributo per quanto mi era richiesto. Poiché non c’era comunicazione tra un reparto e l’altro del nostro stabilimento, separati da un cortile, l’intesa fu che, per avvisarci reciprocamente dell’inizio dello sciopero, avremmo fatto squillare i campanelli. Noi, militanti comunisti e non (pochissimi operai e operaie della fabbrica erano iscritti al partito) ci incaricammo di far trovare sui posti di lavoro i volantini preparatori dell’agitazione, entrando mezz’ora prima degli altri per collocarli in modo che gli operai li vedessero ma sfuggendo così alla sorveglianza esercitata in officina durante le ore di produzione.
Al segnale di sciopero, scendemmo in massa verso il cortile. Davanti stavano le donne: quando si attuava una protesta, mettevano sempre le donne in prima fila, nell’illusione che evitassero le rappresaglie contro gli uomini, non subendo le reazioni della polizia. Poiché non avevamo avuto la possibilità di far squillare i campanelli ai piani alti, dove lavoravano gli uomini, sventolammo i fazzoletti e gli operai ci raggiunsero nei reparti sottostanti. La direzione aveva mandato immediatamente le guardie e noi ci nascondemmo dietro le macchine: quando ne compariva una, la salutavamo con la pernacchia che non si capiva da dove provenisse.
Forse a un certo punto queste guardie ebbero paura. Fatto sta che prima venne su il direttore, dottor Savero; poi anche lui terrorizzato mandò a chiamare il direttore generale, ingegner Mattioli. Costui era un fior di fascista, sempre vestito di orbace, fez in capo e fiocco che gli spioveva sul naso. Quel giorno arrivò in borghese, ci riunì nel reparto mezzo vuoto e si mise a sbraitare: “Che accidenti fate. Guardate che siamo in tempo di guerra, vi possono spedire in Germania. Se avete qualche cosa da dire, ditelo a me”. Nessuno fiatava, e allora io, seduta su una cassa, risposi: “Lei parla bene perché forse a casa sua ha da mangiare: ma noi non possiamo tirare avanti, non abbiamo da mangiare e ci rifiutiamo di lavorare”. Il mio intervento diede coraggio anche agli alti e Mattioli, spaventato, se la diede a gambe.
Lo sciopero proseguì, mi pare due giorni dopo, e il direttore non si fece più vivo. Arrivarono in fabbrica come se avessero poca voglia anche loro di immischiarsi nella faccenda. Le donne li assediavano gridando. Uno dei militi mi apostrofò: “Ma tu che sei alta così, perché non vai a lavorare?” “Sono giovane – gli risposi – ma quando vado a comperare un cavolo (dissi proprio “cavolo”) non vogliono darmelo perché non ho i soldi per pagarlo”. E lo piantai in asso.
Alla terza ondata di sciopero ci mandarono i metropolitani, che si piazzarono sotto il portone della fabbrica con le mitragliatrici, evidentemente per impaurirci; ottennero l’effetto opposto, perché subito cessammo di lavorare.
Di lotta in lotta, imparammo a seguire la situazione politica con la massima attenzione. Nel reparto portammo una grande carta geografica dell’Europa che avevamo acquistato: tutte le mattine per un’ora e mezza, allargavamo la carta sul pavimento e aggiornavamo con delle bandierine l’andamento delle operazioni belliche, segnando i punti delle forze in conflitto.
Durante gli scioperi, c’era l’impegno di mettere in atto dei sabotaggi: ma come attuarli? Avevamo un collaudatore, un vecchietto piuttosto bravo che fingeva di non capire quando alteravamo i cartellini di lavorazione segnando che il lavoro per mettere assieme una cassetta era durato mezz’ora.
“Ma come mai? – chiedeva – non va avanti?”. E lasciava perdere.
(Testimonianza tratta da Quei giorni del marzo 1943. Le donne che sostituivano i richiamati alle armi, in “L’Antifascista”, Anno XL, n.6, giugno 1993, p. 9)
Leggi la Biografia di Arcangela Casetti