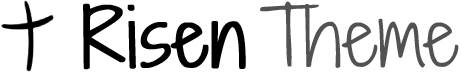Una mattina di gennaio – eravamo in sala di operazione: c’era in programma una laparotomia durante la quale io avrei dovuto assistere il professore ed una plastica vaginale che avrei dovuto eseguire io stessa. Ad un certo momento, divenni cosciente di una specie di agitazione diffusa nell’aria attorno a me, anormale nella pace disciplinata della sala di operazione. In un momento in cui il professore non poneva attenzione, l’infermiera Cesarina mi soffiò all’orecchio che fuori dalla porta c’era il Gadina con due poliziotti che mi stavano aspettando. Il Gadina era il più efferato uomo di mano delle Brigate fasciste. “Ci siamo” – pensai e mi dedicai fervorosamente a pensare da che parte avrei potuto svignarmela, ingannando l’attesa di quei tre. La sala di operazione si trovava in fondo al corridoio ed aveva un solo ingresso. Non ci volle niente per rendermi conto che non avevo scampo. La laparotomia finì: la pazienta della plastica, convenientemente preparata e già sotto l’effetto della sua anestesia basale, aspettava il suo turno. Probabilmente fu l’istinto di temporeggiare che mi fece chiedere al professore, al momento in cui deponeva i guanti di gomma: “Professore, fuori c’è il Gadina colla polizia che mi aspetta; posso operare o debbo andare?”.
Vedo ancora il gesto stizzito con cui buttò i guanti sul tavolo ingombro di strumentario usato: “Fate come volete” – e scappò. Io rimasi e feci la plastica, chiedendo alle mie infermiere di avvertire la famiglia che era lontana nel caso non avessi fatto ritorno. Quello che parve sangue freddo da parte mia fu ricompensato dal fatto che, quando uscii, il Gadina non c’era più.
Era andato col professore che lo conosceva e che probabilmente aveva le mani in pasta con questa vicenda del mio arresto. I due poliziotti aspettarono che mettessi il cappotto e mi accompagnarono a piedi, attraverso la città, che era uguale identica a quella di tutti gli altri giorni, introducendomi nello studio del questore. Non aveva idea delle accuse che mi potevano essere fatte e, data la forma del mio arresto, mi illudevo ancora che non si trattasse se non di un falso allarme. Una cosa del genere mi era già successa da studentessa, proprio il giorno in cui dovevo dare – e detti – l’ultimo esame prima della laurea: quello di pediatria.
Allora ero a Torino ed il capo dell’ufficio politico, dopo essersi inutilmente informato su Kalman e Jani (dei quali, del resto, non sapevo più niente) mi aveva lasciata partire, dicendomi che mi aveva appena chiamata per un’informazione, ma che adesso sapeva che ero una tipa da tenere d’occhio. Magari anche stavolta sarebbe successo lo stesso.
Introdotta nello studio del questore, venni verbalmente aggredita a squarciagola dall’uomo dietro la scrivania. In generale, quando ho paura, io divento sfacciata per farmi coraggio. Deve essere come quando i bambini sbraitano per difendersi dal buio. Mi eressi in tutta la mia virtuosa indignazione e gli dissi che avesse la bontà di non gridare, giacché non ero sorda e del resto “lui era seduto ed io, io ero in piedi”. La cosa funzionò: voleva sapere che parte avevo avuto nella liberazione dei prigionieri di guerra alleati. Siccome non ne avevo alcuni idea, divenni ilare. I miei compagni mi avevano tanto raccomandato di non espormi a quanto non dovevo, giacché ero la responsabile dei Gruppi di difesa, che la mia maggiore paura era quella di essere incorsa in qualche errore per non aver ubbidito.
Non venni picchiata, non venni più insultata. Doveva essere verso mezzogiorno perché il funzionario telefonò alla moglie dicendole di buttare la pasta, ché sarebbe arrivato in dieci minuti, poi mi riconsegnò ad un poliziotto che mi introdusse in una cella fetida e gelida al pian terreno sotto l’androne della questura. Vedevo per la prima volta un tavolaccio ricoperto da una lurida coperta, fiutavo per la prima volta in quelle circostanze l’odore di orine che qualcuno aveva recentemente sparso sul pavimento. Ogni tanto un occhio mi spiava dal finestrino e, non so perché, mi pareva solidale. Una voce giunse a chiedermi chi ero, al che risposi di essere la dottoressa Marengo. Verso le cinque, la porta si aperse e senza ulteriori interrogatorii, venni condotta, sempre a piedi, fra il pubblico della città, nelle carceri provinciali”.
(Tratto da Monica Schettino (a cura di), Una storia non ancora finita. Memorie di Anna Marengo, Varallo, 2014, pp. 68-69)
Ascolta la lettura sulla web radio del progetto (clicca qui)!
Leggi la Biografia di Anna